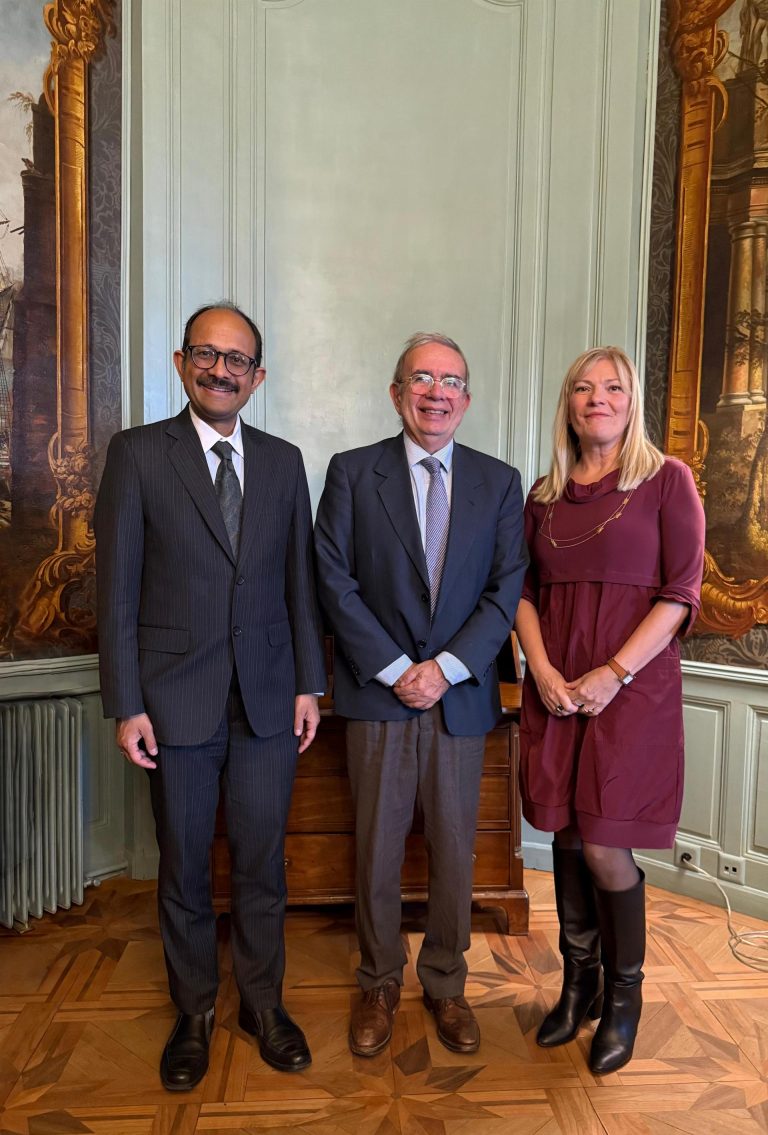Vienna, 11/11/2025
Signora Direttrice Generale,
Signor Presidente Federale dell’Austria,
Signore e Signori Rappresentanti Permanenti,
Signore e Signori,
sono lieto di intervenire alla sessione di apertura in occasione della Giornata per la prevenzione e la lotta a ogni forma di criminalità organizzata transnazionale.
Una giornata alla cui istituzione da parte dell’Assemblea Generale l’Italia ha fornito impulso.
Desidero richiamare l’attenzione sull’importanza che l’Italia attribuisce a tre anniversari che ricorrono in questo 2025: 80 anni dalla fondazione delle Nazioni Unite; 70 anni dall’accesso dell’Italia all’ONU; 25 anni dalla firma della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, la cosiddetta Convenzione di Palermo, che fa parte dei miei ricordi perché ero presente in quell’occasione.
Illustrazione evidente, ove ve ne fosse bisogno, dell’alto valore rappresentato dalla diplomazia multilaterale e dalla costruzione, paziente e ordinata, di istituzioni internazionali chiamate a promuovere il progresso dell’umanità.
Permettetemi alcune riflessioni su ciascuno di questi tre momenti.
La conclusione della Conferenza di San Francisco e l’adozione della Carta delle Nazioni Unite portarono speranza, nel 1945, a un mondo che aveva visto per due volte nell’arco della stessa generazione la furia devastatrice delle guerre globali. Si avviava allora la costruzione di una architettura internazionale basata su regole condivise e sulla cooperazione pacifica fra Stati, tutti egualmente sovrani.
In un percorso durato 80 anni, le Nazioni Unite sono state protagoniste di progressi decisivi, dalla decolonizzazione al sostegno allo sviluppo sociale ed economico di miliardi di persone, dagli interventi per il mantenimento della pace alla difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Oggi l’ONU continua a essere la cornice di riferimento fondamentale per affrontare sfide che travalicano i confini nazionali: la promozione di un’agenda condivisa per la preservazione del nostro pianeta, le sfide poste dall’intelligenza artificiale, la tutela della salute globale, solo per citarne alcune: il crimine organizzato rientra in questa categoria di sfide che richiedono una risposta internazionale costante e coordinata.
In questo lungo percorso non sono mancati ostacoli, errori e lacune, in parte riconducibili a carenze strutturali dell’Organizzazione, in parte all’altalenante volontà politica degli stessi Stati Membri a sostenerne pienamente l’azione.
La recente riforma UN80 varata dal Segretario Generale Guterres è stata avviata per fornire risposta a questa richiesta di maggiore efficacia.
Si tratta di un passo nella giusta direzione che, comunque, sollecita a una riflessione più ampia sugli stessi meccanismi decisionali dell’ONU, a cominciare del Consiglio di Sicurezza, la cui composizione – e i cui poteri in capo ai membri permanenti – riflettono il mondo del 1945.
L’ONU può adempiere al suo mandato di garante della pace internazionale soltanto se gli Stati che ne fanno parte le consentono di farlo. E, tuttavia, le Nazioni Unite restano, pur con tali limiti, uno strumento straordinario e insostituibile di pace e di stabilità, che sarebbe irresponsabile indebolire.
Il quadro geo-politico che abbiamo di fronte, dalla perdurante guerra di aggressione russa all’Ucraina, alla crisi in Medio Oriente, all’instabilità in diverse aree del continente africano, spesso associata a drammatiche crisi umanitarie, richiede con tutta evidenza un sostegno attivo dell’ONU, non certamente il suo smantellamento.
Penso, ad esempio, all’esigenza di rafforzare – e non demolire – l’architettura relativa al disarmo e alla non proliferazione delle armi nucleari, in una fase storica in cui, invece, assistiamo a inaccettabili allusioni all’impiego di armi di distruzione di massa.
Non esistono alternative al multilateralismo, a meno che non si ritenga di imboccare la strada dei conflitti permanenti, con un ritorno ad una visione primitiva dei rapporti fra i popoli, i cui esiti sono storicamente e drammaticamente ben noti.
Riguardo al secondo anniversario – l’adesione italiana alle Nazioni Unite – mi preme ricordare come nello stesso momento in cui nasceva l’ONU, l’Italia intraprendeva il percorso per dotarsi di una nuova Legge fondamentale, la Costituzione repubblicana del 1948, fondata su valori che coincidono con quelli della Carta di San Francisco e della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo.
In quel testo i padri Costituenti italiani, con grande lungimiranza, indicavano espressamente la strada per una partecipazione italiana alle organizzazioni internazionali.
Su queste basi, di piena adesione a un sistema valoriale, la Repubblica Italiana poté accedere alle Nazioni Unite nel 1955, lo stesso anno della Repubblica d’Austria.
Da allora l’Italia, con convinzione, si è fatta protagonista di campagne per la promozione di valori universali, ospitando sul suo territorio importanti strutture dell’Onu.
A questo riguardo, permettetemi di esprimere il mio sentito ringraziamento al Paese che accoglie questo importante Polo onusiano, e a Lei, Signor Presidente Federale – e caro amico – per essere qui oggi a sostenere, insieme, quegli stessi valori che hanno caratterizzato i nostri condivisi 70 anni di appartenenza alla famiglia dell’ONU, in termini etici e politici.
In questa visione comune – e faccio riferimento al terzo punto – rientra anche la Convenzione di Palermo.
Una Convenzione che vide anche una forte volontà dell’Italia che aveva attraversato momenti di proterva aggressione da parte della criminalità organizzata.
Restano impressi nella memoria collettiva, tra gli altri, i sanguinosi attentati del 1992 che costarono la vita a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e, insieme a loro, ai valorosi e coraggiosi agenti delle loro scorte.
Falcone e Borsellino – che ho avuto il privilegio di conoscere e sovente frequentare – avevano inferto alla mafia colpi di grande efficacia e di successo, disvelandone percorsi finanziari, collegamenti, debolezza sociale.
Era l’inizio di una stagione connotata da nuove tecniche investigative: esemplificativo il metodo del sequestro e utilizzo a fini sociali delle ingenti risorse della criminalità organizzata.
Quegli attentati furono l’atto finale di una mafia tracotante, che si riteneva capace di sfidare lo Stato e ne fu, invece, sconfitta.
Il crimine organizzato può essere vinto a patto che le istituzioni e le varie articolazioni della società si riconoscano nei doveri condivisi di civica responsabilità.
È vero nei contesti nazionali ed è vero a livello sovranazionale.
Del resto, come si potrebbe pensare o pretendere di combattere in modo diverso e con successo attività criminali transnazionali?
Giovanni Falcone aveva intuito l’importanza della cooperazione internazionale come strumento per contrastare la criminalità organizzata: dai traffici illeciti alla movimentazione dei proventi di reato per il loro riutilizzo e riciclaggio.
Forte di questa convinzione, Falcone aveva guidato – proprio in questo edificio, come è stato ricordato dalla direttrice poc’anzi – la delegazione italiana alla prima sessione della Commissione ONU per la Prevenzione del Crimine e per la Giustizia Penale, nel 1992, poche settimane prima del suo assassinio.
La sua visione venne condivisa e sviluppata, giungendo all’avvio dei lavori per la redazione della Convenzione di Palermo.
Signore e Signori,
oggi, qui, a Vienna, rinnoviamo solennemente il nostro impegno contro la criminalità organizzata.
Si tratta di una comune responsabilità morale che appartiene alla comunità internazionale nel suo insieme, e deve unirla.
La Convenzione di Palermo, con i suoi Protocolli Addizionali, nasce proprio dalla consapevolezza che il fenomeno della criminalità transnazionale, come tutte le altre sfide globali, può essere affrontato soltanto con un largo concorso di forze.
Da qui deriva la sua perdurante attualità, a 25 anni dalla sua firma. Attualità che ci interpella severamente, a fronte dei risultati che ha saputo concretamente promuovere con riferimento a quella tensione morale, a quel sentimento del dovere, a quella determinazione che Giovanni Falcone riconduceva alla stessa dignità della persona.
Link ufficiale https://www.quirinale.it/elementi/143836